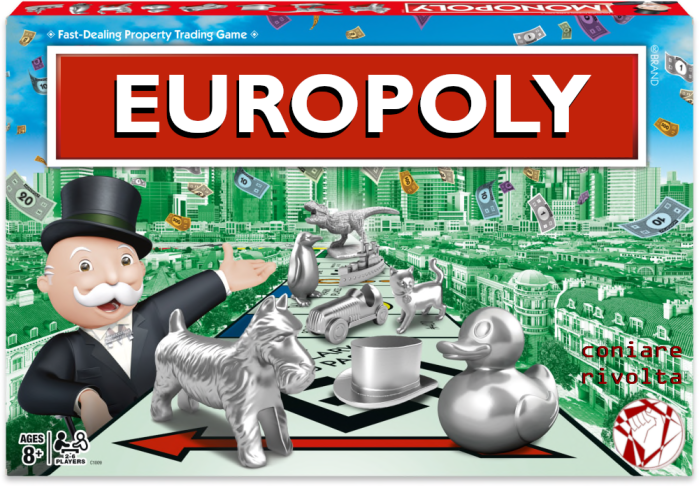
Persino
commentatori di orientamento manifestamente liberista (si veda, ad
esempio, l’uscita dell’economista Francesco Giavazzi)
hanno mostrato un certo imbarazzo sulla vicenda FCA e sulla propensione
delle grandi società a succhiare risorse pubbliche ricordando come le
imprese multinazionali ogni anno sottraggano immense risorse fiscali
agli Stati dove operano tramite la fissazione della propria sede legale in Paesi a fiscalità privilegiata.
Questa massiccia elusione fiscale
praticata dalle grandi società si realizza non solo attraverso i noti
paradisi fiscali extraeuropei (Isole Cayman, Bermuda, Bahamas,
Singapore, etc.), ma anche e soprattutto all’interno dello spazio europeo
dove, data la libera circolazione dei capitali vigente tra i Paesi
membri, vi è l’enorme vantaggio di spostamento della sede all’estero a
costi limitati, anche quando in quel Paese la società considerata svolge
un’attività economica marginale o nulla.
Persino il paladino dell’austerità Carlo Cottarelli si è recentemente pronunciato al riguardo sulle eccessive differenze nella tassazione dei profitti d’impresa tra Paesi: “Nell’Unione
Europea alcuni piccoli paesi attuano politiche fiscali aggressive a
scapito di altri. Il fatto di essere piccoli consente loro, in un
mercato comune, di attirare molti investimenti con una tassazione
favorevole, perdendo poco gettito rispetto a quanto recuperato con
politiche fiscalmente aggressive. È quindi necessario imporre un sistema
di regole che renda più omogenea la legislazione fiscale in modo da non
distorcere l’allocazione delle risorse all’interno dell’Unione”.
Insomma, a distanza di trent’anni
dall’avvio della liberalizzazione dei movimenti di capitale, persino un
alfiere del liberismo come Cottarelli arriva a bollinare come
problematico lo spaventoso meccanismo rappresentato dalla concorrenza
fiscale tra Stati, analogo del resto al meccanismo che genera la
concorrenza salariale e la concorrenza su ogni tipo di normativa
concernente lavoro, ambiente e diritti sociali.
Le modalità tramite cui si articola la
concorrenza fiscale sulla tassazione dei profitti in Europa sono
molteplici. Esistono profonde divergenze nella tassazione delle imprese
che possono riguardare:
- l’aliquota legale, ossia quella che colpisce le società, i cui estremi oscillano tra il 34% della Francia e il 9% dell’Ungheria;
- l’aliquota effettiva, quella di fatto pagata in virtù di meccanismi di deduzione o come risultato di accordi specifici siglati da molte multinazionali con Stati accondiscendenti; si va in questo caso dal 34% della Francia allo 0% di Cipro, Lussemburgo e Irlanda (passando per il 2,4% dell’Olanda e il 5% di Malta);
- l’aliquota pagata sulle rendite finanziarie dalle imprese e dalle persone fisiche.
I sistemi per spostare i profitti da un
Paese ad un altro passano per pratiche elusive consistenti
nell’attribuire ad un’impresa di uno stesso gruppo i profitti
conseguenti da un’altra impresa del gruppo avente sede in un altro Paese
a fiscalità più pesante. Non deve pertanto ingannare il dato stando al
quale Paesi come Malta, Cipro e Lussemburgo mostrino un rapporto
percentuale tra gettito raccolto tramite l’imposta che colpisce le
società e PIL pari a circa il 5-6%, mentre in Italia, a dispetto di
aliquote molto più alte, questa percentuale scende sotto al 2%: si
tratta di economie con un PIL relativamente basso ma che ospitano le
sedi legali di grandi imprese multinazionali che, spesso e volentieri,
finiscono tramite artifici contabili ad attribuire determinati utili
alla specifica impresa del gruppo che ha sede legale in questi Paesi.
In termini di profitti elusi al nostro
Paese questa concorrenza selvaggia consentirebbe, secondo stime
prudenti, circa 34 miliardi ogni anno: redditi che in questo modo
sfuggono al fisco italiano con una perdita di gettito superiore ai 7 miliardi. A fronte di questi dati impietosi il buon senso di chiunque suggerirebbe la necessità di limitare le pratiche elusive
che consentono il trasferimento dei profitti e contestualmente di
giungere ad una qualche forma di armonizzazione fiscale se non a livello
mondiale quanto meno a livello europeo. È questo l’esatto auspicio di
Cottarelli, cui fanno eco su diversi quotidiani vari economisti e
opinionisti che giungono alle medesime conclusioni. Ci sono però due
aspetti cruciali che in tutte queste disamine non emergono affatto.
Il primo punto è che la concorrenza
fiscale e salariale costituisce la base non solo della delocalizzazione
dei profitti, generati in un Paese e spostati altrove, ma anche e
soprattutto della delocalizzazione produttiva,
ovvero dello spostamento effettivo dell’attività produttiva di
un’impresa da un Paese ad un altro. Una dinamica che, per gli Stati con
fiscalità più elevata, dà luogo a gravissime perdite in termini
occupazionali e di gettito fiscale rispetto al livello potenziale
raggiungibile in assenza di fughe di capitali.Questa perdita non viene
neanche menzionata così come non viene discussa la pratica,
evidentemente considerata come naturale esito del libero scambio, della
delocalizzazione produttiva.
In secondo luogo, la partita della
concorrenza tra Paesi generata dalla delocalizzazione fiscale dei
profitti viene presentata come un mero gioco tra Stati per accaparrarsi
il cospicuo gettito sui profitti elusi dove alcuni ‘statarelli’ piccoli e
furbi giocherebbero sporco sottraendo silenziosamente risorse agli
altri Stati. Nel mezzo, le multinazionali a godere di questi enormi
vantaggi. Il tutto viene dipinto come una sorta di accidente, una
spiacevole conseguenza evitabile della globalizzazione dei mercati e,
nello specifico, un errore correggibile del processo di integrazione
europea.
Le cose stanno però diversamente.
La concorrenza fiscale attivata dalla libertà di movimenti di capitale
in presenza di asimmetrie normative è un processo strutturale su cui si
fonda la ratio stessa delle politiche di apertura
indiscriminata agli scambi con l’estero e su cui si è consapevolmente
costruito tutto il processo di unificazione europea in particolare a
partire dagli anni ’80. Non un errore quindi, né uno sgradevole
atteggiamento adottato da Stati furbetti, ma un calcolato piano
orientato ad una redistribuzione massiccia di risorse non solo e non
tanto tra Stati, ma tra capitale e lavoro in tutte le nazioni.
L’esistenza di paradisi fiscali o di
enormi differenziali salariali infatti non solo provoca la
delocalizzazione dei profitti e delle attività produttive, ma
contemporaneamente spinge in modo inesorabile tutti i Paesi ad abbassare
le aliquote fiscali sul capitale, in particolare sulle grandi società,
strutturalmente più mobili e dotate dei mezzi finanziari e organizzativi
che consentono rapidi e indolori spostamenti geografici delle proprie
sedi fiscali o dei propri siti produttivi. Allo stesso identico modo
l’esistenza di differenziali salariali in presenza di libera
circolazione di capitali spinge non solo alla migrazione dei capitali ma
ad una pressione salariale interna a tutti i Paesi (non solo quelli
europei), in specie quelli a salari più alti, verso la riduzione del costo del lavoro.
Questa sciagurata tendenza, peraltro, può essere facilmente avallata
dai governi responsabili della politica economica e persino venduta alle
classi subalterne di ogni Paese come una sorta di circostanza
inesorabile il cui colpevole è solo e soltanto un meccanismo anonimo e
insindacabile: la concorrenza dei mercati internazionali.
Nella narrazione comune in verità una
soluzione teorica verrebbe pure offerta, ma del tutto astratta e
consapevolmente parolaia: quella di ridurre a poco a poco le asimmetrie
fiscali e salariali tra Paesi tramite accordi politici. Ma in quale
direzione? In assenza di una direzione politica orientata a sanare il problema al rialzo, la soluzione la offre la lenta e brutale logica della concorrenza al ribasso.
Il processo di integrazione europea nella sua stessa genesi sta lì a
dimostrarlo con chiarezza lampante. Mentre si cianciava per decenni di
armonizzazione fiscale, norme antielusione, convergenza salariale,
sindacato unico europeo e nulla si faceva in tale direzione invocando la
difficoltà di un processo complesso, nel frattempo si procedeva
speditamente e con sorprendente capacità decisionale alla
liberalizzazione totale dei movimenti di merci e capitali creando lo
spazio unico europeo già dalla fine degli anni ’80. Una liberalizzazione
che ha prodotto una race to the bottom su
salari, fisco, diritti e regolamentazioni dei mercati, con l’ovvio
risultato di ridurre la quota salari sul prodotto, abbassare il carico
fiscale sul capitale e allentare la regolamentazione dei mercati. E
tutto questo non accadeva certo per caso, ma per la genesi costitutiva del processo di integrazione europea,
una sorta di laboratorio della perfetta globalizzazione dei mercati,
ovvero dell’esautorazione progressiva del ruolo dello Stato
nell’economia a tutto vantaggio degli interessi del grande capitale.
Non un accidente dunque, né un errore
emendabile o un terribile sbaglio, ma la ragion d’essere di un assetto
istituzionale che ha guidato e continua a guidare l’enorme processo di
redistribuzione regressiva della ricchezza che segna da 40 anni i sistemi economici europei e del mondo intero.
Cottarelli allora ha piena ragione a
reclamare la messa al bando delle pratiche elusive e l’armonizzazione
fiscale tra Paesi, ma non porta a compimento logico il suo ragionamento.
E non lo fa perché ciò lo costringerebbe a dover rifiutare in blocco, fin dalle premesse, il processo di integrazione europea
e, più in generale, il processo di globalizzazione dei mercati
reclamando un pieno ritorno alla sovranità della sfera politica sui
processi economici con tutte le conseguenze radicali che ciò
comporterebbe in termini di equilibri tra interesse pubblico e interessi
privati e ribilanciamento del conflitto economico tra classi sociali.

Nessun commento:
Posta un commento